Nei giorni della COP30 di Belém, e dopo la spedizione della Flottilla verso Gaza, la domanda che Greta Thunberg fece alle Nazioni Unite nel 2019 è ancora, e sempre più, di attualità. Perché c’è la transizione energetica, ma siamo ancora lontani da una transizione ecologica. E la contrapposizione fra due visioni del mondo - quella ambientalista e quella del capitalismo estrattivista, che cerca soltanto la crescita economica - è sempre più accesa.

Photo Credits Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Non è mai vero che possiamo essere oggettivi. Non c’è un giornalismo davvero imparziale, non c’è un governo che sia solo tecnico, non c’è decisione che sia neutrale, non c’è battaglia che tocchi chiunque. Ogni essere umano (e comunità, e società) è portatore di una visione del mondo, più o meno consapevole, più o meno strutturata e rifinita, e quella visione del mondo si riversa in ogni nostra scelta, preferenza, idea, opinione.
La visione del mondo è quanto di più prezioso e personale abbiamo anche se – e proprio perché – non è mai davvero indipendente: si porta dietro la nostra storia personale e sociale, cambia quando una nuova scoperta le dà una spallata, si trasforma se spintonata da un evento o da un trauma. Soprattutto si inscrive in uno Zeitgeist, uno spirito del tempo, e per questo ci ricorda che non siamo individui isolati ma parte di ragnatele di pensieri, bisogni, desideri e convinzioni tessute all’interno delle società e comunità in cui nasciamo e che scegliamo.
La nostra visione del mondo appartiene un po’ solamente a noi, e molto a tanti altri, quasi a cerchi concentrici: un nucleo solo nostro, e anelli sempre più ampi condivisi con una comunità sempre più grande e trasversale.
Sono visioni del mondo diverse quelle che ci spingono a volere la pace o la guerra, a votare una legge preventiva o una legge punitiva, a preferire un pianeta sano o la crescita economica. Sempre nella Storia si sono scontrate visioni del mondo. Se ne scontrano anche oggi, nelle piazze e nei giornali. Tante, sottili, ma sempre intersecate fra loro.
Poche settimane fa si affrontavano alle porte di Israele, quando la Flotilla si è trovata davanti all’esercito israeliano, ed erano le stesse visioni del mondo opposte che sei anni fa si guardavano in cagnesco all’Onu, Greta Thunberg da un lato e Donald Trump dall’altro.
Diverse concezioni della realtà si scontrano in ogni dibattito sulla guerra, sull’energia, sul welfare, sulla crisi climatica, sui diritti, sull’economia e sono del tutto connesse fra loro. Non possiamo volere la giustizia climatica e il neoliberalismo, o la giustizia climatica e la libertà di un popolo di schiacciarne un altro. Per questo la Greta Thunberg che chiedeva ai potenti del mondo “Come osate non fare niente?” di fronte al disastro climatico incombente è del tutto coerente con la Greta Thunberg sulla Flotilla – una Flotilla che in fondo chiede alla comunità internazionale proprio la stessa cosa: “Come osate non fare niente?” . Queste lotte hanno a che fare con una visione del mondo, che è sempre stata la stessa però nel tempo si è fatta più estesa, complessa e radicata.
Non possiamo volere la giustizia climatica e il neoliberalismo, o la giustizia climatica e la libertà di un popolo di schiacciarne un altro.

Photo Credits Kushal Das, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Nel suo discorso del 2019 Thunberg diceva: “Ci sono persone che soffrono e che muoiono, interi ecosistemi sono al collasso, siamo all’alba di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui riuscite a parlare sono i soldi e le favole (fairytales) di un’eterna crescita economica”.
Greta è sempre stata di parte perché la lotta alla crisi climatica è di parte. È la parte della maggioranza delle persone, dei più deboli, del sud globale, del bene comune, della salute del pianeta e quindi di chi ci vive: ma è pur sempre una parte. E fin da quel primo discorso metteva al banco degli imputati la “favola” dell’eterna crescita economica come priorità massima attraverso cui leggere ogni cosa: le scelte politiche ed economiche da prendere, le leggi da promulgare, lo stato di salute di un paese, l’opportunità o meno di sfruttare aree del mono o classi sociali. Non parlava di scienza, parlava di politica.
Recentemente è uscito un romanzo intitolato I quattro che predissero la fine del mondo di Abel Quentin, che racconta la storia degli autori del Rapporto sui limiti dello Sviluppo uscito nel 1972.
Il rapporto all’inizio fece un gran boato e gli autori vennero invitati dappertutto a parlarne, negli Stati Uniti e in Europa, nelle università e nelle stanze del potere. Poi arrivarono l’ostilità e la damnatio memoriae. Quentin scrive “Avevano creduto che essere ricevuti ovunque equivalesse a essere ascoltati ovunque […], che l’urgenza avrebbe conquistato chiunque”, invece “erano stati ricevuti da quella gente solo perché non si sentiva minacciata da loro”.
È proprio così: anche Greta sei anni fa veniva ricevuta perché non faceva paura, e del suo messaggio si amplificavano le parti che potevano mettere d’accordo quasi tutti, mentre passava in secondo piano l’accusa al sistema economico dominante e alla visione del mondo di cui quel sistema è portatore. Il punto è sempre stato il neoliberismo in particolare, il capitalismo in generale, l’estrattivismo come approccio al pianeta e all’esistenza, il patriarcato come sistema di dominio impune sulle cose e sulle persone.

I quattro che predissero la fine del mondo di Abel Quentin, Edizioni E/O.
Dai tempi in cui Greta veniva ricevuta nelle stanze del potere è cambiato tutto, da entrambi i lati della barricata. Oggi nessuno la riceverebbe più, anzi: la bombardano in mare, come un pirata.
Certo, un’apparente vittoria c’è stata: la transizione energetica è partita ed è inarrestabile. Lo sa persino Trump che con una mano garantisce il più a lungo possibile massimi profitti per le big del fossile e con l’altra cerca metalli e terre rare. È una transizione enorme, con quasi l’intero parco auto della Cina ormai convertito in elettrico, e paesi del continente africano come la Sierra Leone che (sempre dalla Cina) hanno importato pannelli solari per il 61% del loro fabbisogno di elettricità. Ma gli appelli degli ambientalisti sono stati ascoltati con un orecchio solo, quello che sente i soldi e il mantra dell’eterna crescita economica. Si è parlato, come già si faceva da trent’anni, di crediti di carbonio, ETS 1 ed ETS 2; si sono promulgati Green Deal e Inflation Reduction Act, l’Europa è anche in linea con le promesse di abbattimento delle emissioni, ma intanto investe in combustibili fossili e biocarburanti all’estero e qui in industria bellica, mentre per il resto si deindustrializza esternalizzando e cancellando posti di lavoro.
C’è la transizione energetica, non c’è alcuna transizione ecologica. Rispetto al 2015, anno degli Accordi di Parigi, oggi le prospettive di aumento delle temperature sono indiscutibilmente migliorate, anche se non abbastanza: allora andavamo incontro a un aumento di oltre 4 gradi da lì a fine secolo, ora la curva si è abbassata attorno ai due gradi e mezzo. Ma la plastica nei mari, i pfas nelle acque dolci, gli inquinanti, il consumo di suolo e di acqua, la biodiversità, lo sfruttamento di risorse, animali, persone. Transizione ecologica è molto di più.
Il movimento ambientalista però non ci è cascato. Per questo non è odiato solo dalle big del fossile ma anche dai governi. Si è accorto della presa in giro, come si è accorto che non ci si può fidare di istituzioni che si dicono paladine di valori democratici e non muovono un muscolo davanti 67.000 morti dall’altro lato del Mediterraneo, stringono e rinnovano accordi raccapriccianti con la Libia, investono in armi e gas statunitensi.
La transizione energetica nel capitalismo e nel neoliberalismo è possibile. È possibile in un mondo in cui le istituzioni democratiche usano pesi e misure diverse a seconda delle alleanze, riempiendo di sanzioni la Russia e di armi Israele. In un mondo in cui si accetta serenamente un ecocidio, come quello che è avvenuto in Palestina – e ricostruire è sempre un grande business. Non solo è possibile: ormai chi non la cavalca si inabissa e chi la guida vince, come ha capito la Cina.

Ampia area industriale con fumo che esce dalle ciminiere. Photo via Adobe Stock.
La transizione ecologica no. La transizione ecologica presuppone un cambio di passo profondo: una visione del mondo, dell’economia, della politica completamente diversa da quella vigente. Presuppone un modello economico non estrattivista, non è compatibile con la guerra e con le armi, non è compatibile con un ecocidio né con un genocidio, non è compatibile con lo sfruttamento del sud globale da parte del nord globale. Non ha come obiettivo la crescita produttiva e il potere economico dei feudatari dell’agrobusiness, del fossile, della logistica, del tech, ma il benessere, il bene comune, la salute delle persone e del pianeta. E dunque la lotta alle disuguaglianze, la redistribuzione, la pace. È una visione del mondo opposta, in cui tutto si tocca e tutto c’entra.
Gli ambientalisti, dicevamo, lo hanno capito. Certamente Greta Thunberg lo ha sempre saputo, lo diceva chiaro e tondo nel 2019, ma man mano ha iniziato a gridarlo più forte, a essere nelle fabbriche perché il lavoro dovrebbe essere il principale alleato dell’ecologismo, e perché senza lavoratori non c’è transizione ecologica possibile. Transizione ecologica implica cura: per la terra di tutti, l’aria di tutti, l’acqua di tutti, la vita di ciascuno. Non ha a che fare con grandi rinunce – se non per pochi – ma con un’enorme ridistribuzione di risorse e di diritti (alla salute, al cibo sano, a lavori che non siano estrattivi).
Come nel 1972 gli scienziati che scrissero il Rapporto sui limiti dello Sviluppo vennero ricevuti finché con la crisi del petrolio del ’73 forse le loro istanze non iniziarono a fare paura, l’ambientalismo classe 2019 è stato accettato fintanto che si è potuto credere che si parlasse solo di scienza, e che si chiedesse al mondo solamente di cambiare business. Produrre infinite auto elettriche, anziché slegarsi almeno in parte dall’auto privata; investire in rinnovabili, ma anche nel nucleare, e intanto aumentare i consumi energetici a dismisura perché le rinnovabili accompagnino ma non sostituiscano. E lasciare libero sfogo al petrolio nella produzione di plastica. E la guerra, le armi, le ricostruzioni.
Quando l’ambientalismo ha cominciato a dire chiaro e tondo che tutto questo non bastava, a gridare più forte e a unire i puntini delle lotte – dagli oleodotti in Uganda alle coltivazioni di ricino in Kenya, dalla fabbrica ex GKN al genocidio a Gaza – è stato criminalizzato con una durezza inedita in tutto l’Occidente.
La transizione ecologica presuppone un cambio di passo profondo: una visione del mondo, dell’economia, della politica completamente diversa da quella vigente
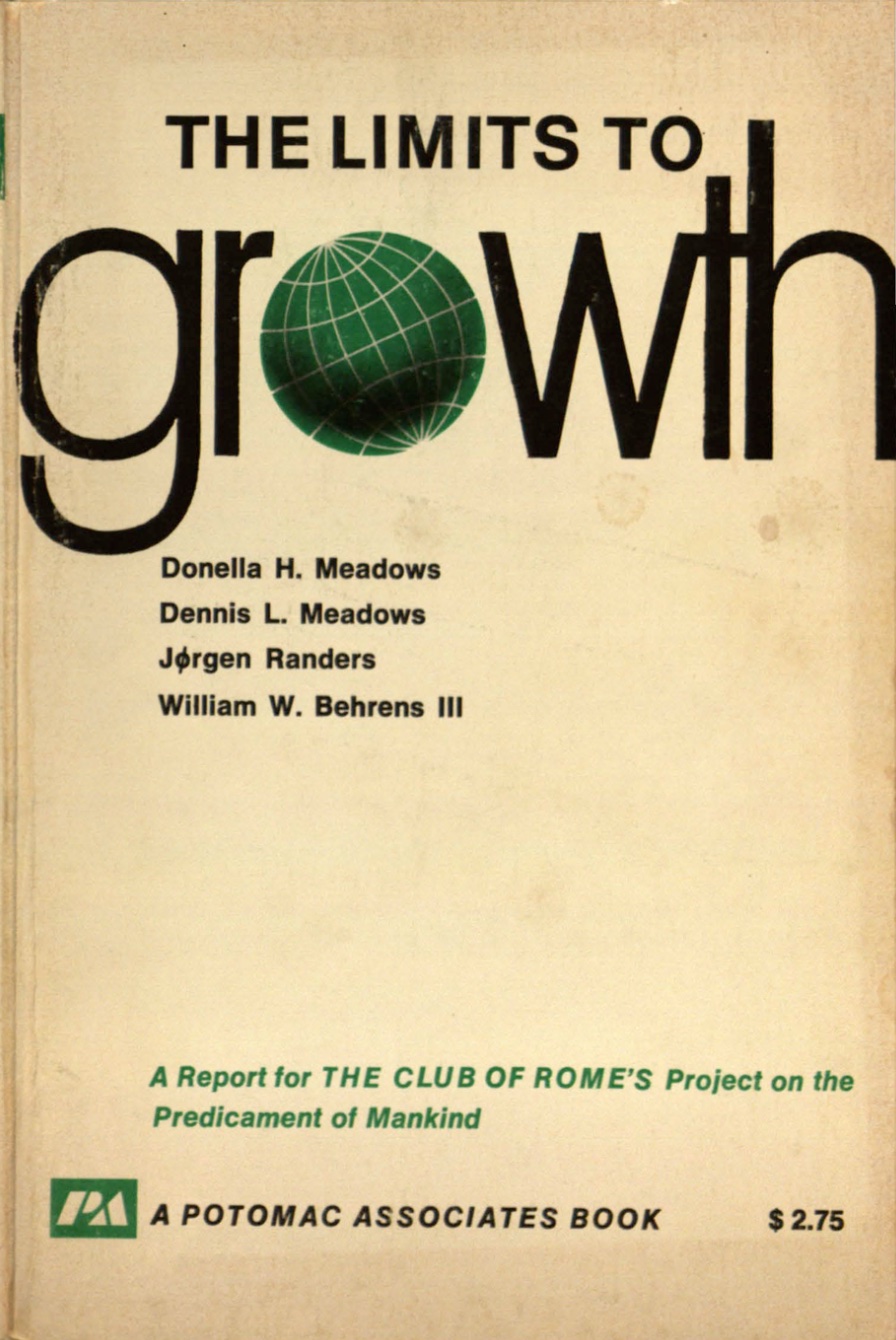
The Limits to Growth, Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III.
Se c’è una consapevolezza ecologica che si è sedimentata in questi anni, è questa: l’aver accettato che siamo sempre di parte, che l’ecologismo è di parte e proprio per questo interseca altre lotte. Lo slogan della fabbrica ex-GKN ce lo ricorda: ci si batte sempre “per questo, per altro, per tutto”.
Del resto, niente è mai imparziale. Non lo è un governo, una lotta, un articolo di giornale, nemmeno una Costituzione.
La nostra si fonderebbe sull’antifascismo e parla di lavoro, libertà di stampa, uguaglianza; ripudia la guerra; per tanti decenni è stata basata sul welfare – la scuola pubblica, la sanità pubblica. E tutto questo fa parte di una visione del mondo. Vale lo stesso per l’Europa. Sembra che ce ne siamo dimenticati.




